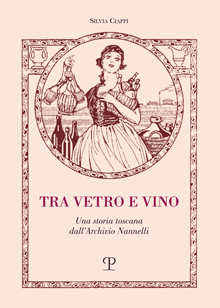Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Non è possibile comprendere l’evoluzione del vino nei secoli senza conoscere la storia e le trasformazioni dei recipienti
Non è possibile comprendere l’evoluzione
del vino nei secoli senza conoscere la storia e le trasformazioni dei
recipienti. Dalla storia del fiasco, all’utilizzo delle bottiglie fino alla
nascita e allo sviluppo dell’enologia moderna, questo è il percorso seguito nel
volume di Silvia Ciappi Tra vetro e vino.
Una storia toscana dall’Archivio Nannelli che, già nel titolo, anticipa il
contenuto, o per meglio dire, i diversi protagonisti della storia narrata. Come
in uno scenario teatrale si alternano e si sovrappongono le diverse vicende: il
vetro, le vetraie, il lavoro dei vetrari e delle «fiascaie», il vino e il
miglioramento della sua qualità. Fanno da sfondo, in un arco di tempo compreso
tra l’inizio del XVIII secolo e gli anni ’50 del ‘900, la trasformazione della
viabilità stradale, ferroviaria e marittima, il ruolo affidato alla pubblicità
dei prodotti attraverso cartoline e listini e,non ultimo, il mutamento
urbanistico e sociale dei centri dell’area empolese dediti alla produzione di
vetro. Silvia Ciappi, fiorentina, che da anni si interessa della storia del
vetro attraverso la ricerca archivistica e iconografica, ha più volte ribadito
l’importanza storico-documentaria del binomio vetro-vino e dello scambievole
rapporto tra contenitore e contenuto, per giungere, da una duplice angolazione,
a una conoscenza ravvicinata delle vicende enologiche e manifatturiere toscane.
La ricerca svolta nell’archivio della famiglia Nannelli, dedita alla produzione
di vetro in una scambievole correlazione. Il filo conduttore dell’intero volume
riguarda l’evoluzione della qualità del vino toscano, dalla coltura, ai
processi di vinificazione e alla commercializzazione: elementi che hanno
determinato netti cambiamenti nell’economia vinicola e favorito il progresso
tecnologico delle fornaci da vetro, impegnate a sperimentare particolari
accorgimenti per favorire la conservazione del vino assicurando l’integrità del
tradizionale fiasco. Era, infatti, indispensabile che il collo e la bocca dei
fiaschi fossero più spessi per consentire la chiusura ermetica con tappi di
sughero a pressione, ma anche un’impagliatura più robusta per i recipienti
destinati a compiere lunghi viaggi. Dall’unione del vino con il fiasco derivava
il naturale accostamento dei prodotti regionali, sinonimi di qualità e di
un’immediata connotazione geografica da imporre sul mercato internazionale. Il
libro è preceduto dalla presentazione di Cristina Acidini che ha posto in
risalto il valore documentario delle fonti iconografiche, indispensabili per
conoscere la forma degli oggetti in vetro, e del fiasco in particolare, e
comprendere, attraverso le immagini pittoriche, la funzione quotidiana: dalla
dispensa, alla mensa più modesta, al banchetto cortigiano. Zeffiro Ciuffoletti
ha, invece, sottolineato l’importanza documentaria degli archivi aziendali che
restituiscono un’immagine articolata e oggettiva di un periodo storico,
fornendo diverse chiavi di lettura e la possibilità di comprendere notizie e
avvenimenti, apparentemente disgiunti. Il volume si articola in sette sezioni:
l’inizio dell’attività vetraia a La Torre, frazione di Montelupo fiorentino,
tra il XVII e il XVIII secolo, l’affermazione imprenditoriale dei Nannelli
dalle origini alla prima metà dell’800. Due paragrafi sono dedicati al fiasco.
Il tradizionale contenitore da vino e da olio, oggetto di severe normativa
legislative, per evitare le continue frodi sulle tasse sul vino subì varie
trasformazioni nella forma e nella disposizione dell’impagliatura che sono
documentate dalle immagini pittoriche sulla struttura e le diverse
utilizzazioni: per il vino, l’olio, per conservare i medicamenti da speziera,
unguenti per la bellezza delle dame rinascimentali o per commerciare le acque
termali di Montecatini. Nell’800 il fiasco fu oggetto di accesi dibattiti per la
necessità di apportare modifiche alla sua tradizionale struttura e soprattutto
supplire alla fragilità del lungo collo e alla conseguente impossibilità di una
chiusura a pressione con tappi di sughero. Era sempre più netto l’intento di
sostituire il fiasco con le bottiglie, più robuste, agili, ma anche anonime, e
confinare quel tradizionale contenitore al mercato vinicolo locale, in tragitti
brevi, dal produttore al consumatore. La resistenza delle vetrerie toscane per
mantenere la produzione del fiasco, fonte di lavoro per un ampio indotto, fu
tenace e tanto forte quanto quel recipiente era radicato nella tradizione
toscana. Il capitolo sul miglioramento del vino ripercorre le principali fasi
del progresso enologico che coinvolse protagonisti di diversa formazione. Essi
presentarono relazioni e saggi dell’Accademia dei Georgofili che, con spirito
innovativo e fervore scientifico di stampo Illuminista, si fece portavoce di
diffondere le novità. L’ultimo capitolo, che riguarda la prima metà del ‘900,
ripercorre l’attività della famiglia Nannelli, titolari di due vetrerie di
Empoli e di quella storica di Fibbiana, ma anche legati da accordi societari
come le più importanti fornaci dell’area empolese e dell’emergente polo
livornese, o con ditte che si occupavano della vestizione dei fiaschi e degli
oggetti di bufferia e di imballaggio dei trasporti. È emersa l’intensa attività
imprenditoriale svolta dai vari componenti della famiglia Nannelli, ma è anche
risultata una fitta rete di rapporti finanziari, spesso convalidata da legami
di amicizia e di parentela, oltre che da un profondo rispetto delle radici
familiari che hanno fatto si che l’archivio Nannelli sia rimasto integro,
restituendo notizie e informazioni che vanno oltre le storie parallele del
vetro e del vino.
Data recensione: 13/09/2020
Testata Giornalistica: Toscana Oggi
Autore: Lorella Pellis