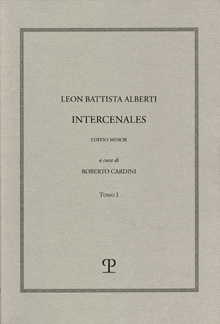Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
L’immagine del Rinascimento è profondamente cambiata negli ultimi decenni: il vecchio mito di un mondo armonico
Leon Battista Alberti. Le «Intercenales» sono un capolavoro
di umorismo del Rinascimento eppure rappresentano una delle riflessioni più
profonde e amare sulla condizione umana
L’immagine del Rinascimento è profondamente cambiata negli ultimi decenni: il vecchio mito di un mondo armonico, sereno, si è definitivamente incrinato, e si è imposta una nuova visione che sottolinea i caratteri drammatici, anche tragici, di quell’epoca straordinaria.
Questo non vuol dire che non vi siano stati personaggi di prima grandezza che hanno insistito sulla dignitas hominis, sulla possibilità per l’uomo di farsi quasi deus, ma oggi sarebbe difficile assumere, come è stato fatto per molti secoli, l’Oratio di Giovanni Pico della Mirandola come il manifesto dell’umanesimo. Certo, la sua voce continua ad arrivare fino a noi, ma è solo una fra molte altre che sottolineano in modo tenace i confini della condizione umana, l’impossibilità di uscire dal proprio limite, il carattere dell’uomo come piccolo «uccello di rapina», in grado di incidere sul proprio tempo solo quando ci sia un riscontro tra la propria virtù e la fortuna, cioè il tempo, che muta senza sosta, mentre la natura umana resta ferma, statica.
Sono, queste, le posizioni di Machiavelli; ma quelle di Guicciardini sono perfino più gravi e drammatiche. Al suo sguardo, totalmente disincantato, il mondo appare privo di un significato visibile, senza alcuna traccia della presenza di Dio. Nella Storia d’Italia, di fronte al sacco di Roma e alla violenza dei lanzichenecchi sulle matrone romane, Guicciardini afferma che i «giudizi di Dio» sono troppo misteriosi per essere compresi con gli strumenti umani. Tema, questo, presente anche nei Ricordi, ma esso attraversa tutta la sua meditazione sulla condizione umana osservata con un giudizio nel quale vibra una nota che si potrebbe definire di tipo nichilistico. Guicciardini pensa, e non è il solo, di vivere in un’età del caos, disordinata, in cui tutti i princìpi del vecchio mondo sono incrinati e prossimi a finire. Il che non vuole dire che l’uomo non debba battersi contro il potere della Fortuna, della «necessità» che incombe sul destino umano.
Ma una visione drammatica della condizione umana, per quanto intrisa di sarcasmo e di umorismo, era già presente in un protagonista dell’umanesimo, Leon Battista Alberti, e attraverso la traduzione dei suoi Opuscoli morali, fra cui il Momus, pubblicata a Venezia nel 1568, si era imposta in Europa presso autori di prima grandezza. È difficile, infatti, che Shakespeare delineando i tratti di Jago non avesse presente appunto il Momus, cui lo avvicinano motivi tipici della cultura umanistica a cominciare da quello, centrale, del simulare e del dissimulare, oltre al grande tema, che aveva origine in Pindaro, dell’uomo «ombra di sogno».
Anche l’immagine di Alberti è profondamente mutata negli ultimi decenni rispetto alle antiche interpretazioni che hanno visto a lungo in lui il rappresentante del Rinascimento tradizionalmente inteso. Né c’è dubbio che alla base di questa nuova immagine ci sia stata la scoperta di «venticinque intercenali sconosciute». Fu Eugenio Garin a individuarle, come ha raccontato lui stesso. Garin pubblicò nel 1964 su «Rinascimento» le Intercenali ritrovate, ristampandole poi, l’anno successivo, in un «Quaderno di “Rinascimento” », e le commentò in una serie di saggi raccolti poi nel volume Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo pubblicato nel 1975. Sono saggi in cui elaborò un “ritratto” assai diverso dalle interpretazioni che egli stesso aveva dato in scritti precedenti, e che è alle origini – insieme ai lavori di Manfredo Tafuri – dell’immagine di Alberti che si è ormai affermata, distanziandosi da antiche visioni sia di Alberti che del Rinascimento.
Di fatto, la scoperta di quelle venticinque Intercenali ha contribuito ad aprire una nuova stagione degli studi sul Rinascimento, che si distanzia nettamente dalla tradizione critica costruita in primo luogo dalla grande storiografia illuministica di d’Alembert e Voltaire e ripresa e sviluppata nell’Ottocento da Michelet e da Burckhardt. Quella lunga tradizione, che aveva le sue radici nella storiografia del Rinascimento, a sua volta perno centrale dell’autobiografia degli intellettuali europei moderni, è entrata in crisi anche grazie a quella scoperta, fino a configurarsi per quello che essa era: un capitolo di alta riflessione storiografica trasformatasi, poi, in un evento di carattere propriamente storico rovesciando il rapporto tra storia e storiografia. Quella scoperta ha contribuito a ristabilire la distanza fra storia e storiografia, senza più considerare, come si è fatto a lungo, realtà storica ciò che era invece una peculiare, e fortunata, valutazione di tipo storiografico.
È dunque molto importante che in questi ultimi decenni siano state approntate varie traduzioni e nuove edizioni delle Intercenali albertiane, che hanno il merito di mettere in circolazione un tesoro così importante.
Nell’ambito delle edizioni, è da segnalare ora la editio minor delle Intercenales a cura di Roberto Cardini, che oltre al testo critico presenta anche la traduzione di Maria Letizia Bracciali Magnini. Editio minor perché essa «riproduce, ma ulteriormente rivisto, il testo critico dell’editio maior», cioè del testo delle Opere latine di Alberti uscite nel 2010. Iniziativa assai utile per gli studiosi interessati a un autore così importante e a testi così suggestivi.
Come dice giustamente Cardini, «a partire dalle Intercenales fino al Momus, i suoi scritti comici non sono, per l’Alberti, vacanza e evasione dalla morte, non sono roba da carnevale, e neppure sono un “rilassamento”, una “distensione fisica e psichica”: sono una terapia e un’autoterapia, ma anzitutto sono conoscenza, sono un “genus quoddam philosophandi”». Sono una delle riflessioni più profonde e più amare sulla condizione umana, fino, si è detto, a Shakespeare, che riprende nelle sue tragedie temi tipicamente albertiani – dalle Intercenali fino, soprattutto, al Momus.
Si potrebbe osservare che Alberti non è un “filosofo”, e che i suoi interessi sono di natura diversa. Non per nulla nella sua figura, per la complessità e la varietà degli interessi, si è visto a lungo l’uomo tipico del Rinascimento. Ma non esiste un concetto unico della filosofia che attraversi, indifferente, tutte le epoche. È vero il contrario: se l’oggetto della filosofia è in primo luogo l’analisi della condizione umana, essa si sviluppa in modi differenti in diversi contesti. E si connette, volta per volta, a discipline che in ogni epoca sono al centro della riflessione sul destino dell’uomo. Questo vale, naturalmente, anche per Alberti.
L’immagine del Rinascimento è profondamente cambiata negli ultimi decenni: il vecchio mito di un mondo armonico, sereno, si è definitivamente incrinato, e si è imposta una nuova visione che sottolinea i caratteri drammatici, anche tragici, di quell’epoca straordinaria.
Questo non vuol dire che non vi siano stati personaggi di prima grandezza che hanno insistito sulla dignitas hominis, sulla possibilità per l’uomo di farsi quasi deus, ma oggi sarebbe difficile assumere, come è stato fatto per molti secoli, l’Oratio di Giovanni Pico della Mirandola come il manifesto dell’umanesimo. Certo, la sua voce continua ad arrivare fino a noi, ma è solo una fra molte altre che sottolineano in modo tenace i confini della condizione umana, l’impossibilità di uscire dal proprio limite, il carattere dell’uomo come piccolo «uccello di rapina», in grado di incidere sul proprio tempo solo quando ci sia un riscontro tra la propria virtù e la fortuna, cioè il tempo, che muta senza sosta, mentre la natura umana resta ferma, statica.
Sono, queste, le posizioni di Machiavelli; ma quelle di Guicciardini sono perfino più gravi e drammatiche. Al suo sguardo, totalmente disincantato, il mondo appare privo di un significato visibile, senza alcuna traccia della presenza di Dio. Nella Storia d’Italia, di fronte al sacco di Roma e alla violenza dei lanzichenecchi sulle matrone romane, Guicciardini afferma che i «giudizi di Dio» sono troppo misteriosi per essere compresi con gli strumenti umani. Tema, questo, presente anche nei Ricordi, ma esso attraversa tutta la sua meditazione sulla condizione umana osservata con un giudizio nel quale vibra una nota che si potrebbe definire di tipo nichilistico. Guicciardini pensa, e non è il solo, di vivere in un’età del caos, disordinata, in cui tutti i princìpi del vecchio mondo sono incrinati e prossimi a finire. Il che non vuole dire che l’uomo non debba battersi contro il potere della Fortuna, della «necessità» che incombe sul destino umano.
Ma una visione drammatica della condizione umana, per quanto intrisa di sarcasmo e di umorismo, era già presente in un protagonista dell’umanesimo, Leon Battista Alberti, e attraverso la traduzione dei suoi Opuscoli morali, fra cui il Momus, pubblicata a Venezia nel 1568, si era imposta in Europa presso autori di prima grandezza. È difficile, infatti, che Shakespeare delineando i tratti di Jago non avesse presente appunto il Momus, cui lo avvicinano motivi tipici della cultura umanistica a cominciare da quello, centrale, del simulare e del dissimulare, oltre al grande tema, che aveva origine in Pindaro, dell’uomo «ombra di sogno».
Anche l’immagine di Alberti è profondamente mutata negli ultimi decenni rispetto alle antiche interpretazioni che hanno visto a lungo in lui il rappresentante del Rinascimento tradizionalmente inteso. Né c’è dubbio che alla base di questa nuova immagine ci sia stata la scoperta di «venticinque intercenali sconosciute». Fu Eugenio Garin a individuarle, come ha raccontato lui stesso. Garin pubblicò nel 1964 su «Rinascimento» le Intercenali ritrovate, ristampandole poi, l’anno successivo, in un «Quaderno di “Rinascimento” », e le commentò in una serie di saggi raccolti poi nel volume Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo pubblicato nel 1975. Sono saggi in cui elaborò un “ritratto” assai diverso dalle interpretazioni che egli stesso aveva dato in scritti precedenti, e che è alle origini – insieme ai lavori di Manfredo Tafuri – dell’immagine di Alberti che si è ormai affermata, distanziandosi da antiche visioni sia di Alberti che del Rinascimento.
Di fatto, la scoperta di quelle venticinque Intercenali ha contribuito ad aprire una nuova stagione degli studi sul Rinascimento, che si distanzia nettamente dalla tradizione critica costruita in primo luogo dalla grande storiografia illuministica di d’Alembert e Voltaire e ripresa e sviluppata nell’Ottocento da Michelet e da Burckhardt. Quella lunga tradizione, che aveva le sue radici nella storiografia del Rinascimento, a sua volta perno centrale dell’autobiografia degli intellettuali europei moderni, è entrata in crisi anche grazie a quella scoperta, fino a configurarsi per quello che essa era: un capitolo di alta riflessione storiografica trasformatasi, poi, in un evento di carattere propriamente storico rovesciando il rapporto tra storia e storiografia. Quella scoperta ha contribuito a ristabilire la distanza fra storia e storiografia, senza più considerare, come si è fatto a lungo, realtà storica ciò che era invece una peculiare, e fortunata, valutazione di tipo storiografico.
È dunque molto importante che in questi ultimi decenni siano state approntate varie traduzioni e nuove edizioni delle Intercenali albertiane, che hanno il merito di mettere in circolazione un tesoro così importante.
Nell’ambito delle edizioni, è da segnalare ora la editio minor delle Intercenales a cura di Roberto Cardini, che oltre al testo critico presenta anche la traduzione di Maria Letizia Bracciali Magnini. Editio minor perché essa «riproduce, ma ulteriormente rivisto, il testo critico dell’editio maior», cioè del testo delle Opere latine di Alberti uscite nel 2010. Iniziativa assai utile per gli studiosi interessati a un autore così importante e a testi così suggestivi.
Come dice giustamente Cardini, «a partire dalle Intercenales fino al Momus, i suoi scritti comici non sono, per l’Alberti, vacanza e evasione dalla morte, non sono roba da carnevale, e neppure sono un “rilassamento”, una “distensione fisica e psichica”: sono una terapia e un’autoterapia, ma anzitutto sono conoscenza, sono un “genus quoddam philosophandi”». Sono una delle riflessioni più profonde e più amare sulla condizione umana, fino, si è detto, a Shakespeare, che riprende nelle sue tragedie temi tipicamente albertiani – dalle Intercenali fino, soprattutto, al Momus.
Si potrebbe osservare che Alberti non è un “filosofo”, e che i suoi interessi sono di natura diversa. Non per nulla nella sua figura, per la complessità e la varietà degli interessi, si è visto a lungo l’uomo tipico del Rinascimento. Ma non esiste un concetto unico della filosofia che attraversi, indifferente, tutte le epoche. È vero il contrario: se l’oggetto della filosofia è in primo luogo l’analisi della condizione umana, essa si sviluppa in modi differenti in diversi contesti. E si connette, volta per volta, a discipline che in ogni epoca sono al centro della riflessione sul destino dell’uomo. Questo vale, naturalmente, anche per Alberti.
Data recensione: 26/02/2023
Testata Giornalistica: Il Sole 24 Ore
Autore: Michele Ciliberto