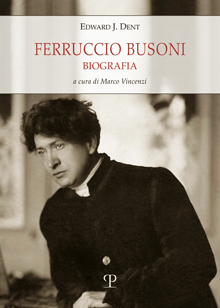Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Ferruccio Busoni ha patito in vita e ancora patisce, dopo quasi un secolo dalla morte di non essere valutato
A 150 anni dalla nascita lo celebra il centro studi a lui dedicato
a Empoli. E Polistampa pubblica la prima biografia del musicista scritta nel
1933 dall’inglese Edward J. Dent
Ferruccio Busoni ha patito in vita e ancora patisce, dopo quasi un secolo dalla morte di non essere valutato, come compositore, quanto meriterebbe. Sulla grandezza del pianista tutti concordano, mentre a proposito delle sue partiture i giudizi divergono drasticamente, e di certo non sono mai entrate in repertorio, tranne qualche trascrizione pianistica dall’adorato Bach (la “Ciaccona”, per esempio). Il 1° aprile Empoli, suo luogo natale, ne celebra online il centocinquantacinquesimo compleanno con diverse iniziative che il Centro studi a lui intitolato propone a grandi e piccini. Occasione per ravvivarne la memoria presso il grande pubblico che fa il paio con l’uscita recente in traduzione italiana, per Polistampa, della prima biografia mai apparsa sul musicista: quella, datata 1933, dell’inglese Edward J. Dent, che per restituire il profilo umano e artistico dell’amico Ferruccio poté contare su ricordi di prima mano e attingere a tanta documentazione privata messagli disposizione dalla vedova Gerda. «Busoni si sentiva un inattuale, sebbene fosse consapevole di costituire un’eccellenza compositiva della sua epoca. Sapeva di aver trovato una strada originalissima, anche se non compresa dai colleghi e dal pubblico. Né, d’altro canto, il venire annoverato tra i più grandi pianisti d’ogni tempo, accanto a Liszt, gli interessava troppo», spiega il curatore del volume Marco Vincenzi, pianista, docente al Conservatorio di Genova e già direttore del Centro studi empolese. Forse, per essere più apprezzato come autore, avrebbe dovuto seguire il consiglio di George Bernard Shaw, che gli suggerì di scrivere sotto pseudonimo, poiché la gente non ammette che una persona sia in grado di far bene più di una cosa, e se uno è già un gran virtuoso del piano si ritiene impossibile che possa pure eccellere nella composizione. «Oggi Busoni continua a restare un inattuale», aggiunge Vincenzi. «Il fatto è che ha abitato un’età di crisi del linguaggio musicale, quando lo sgretolamento della tonalità ha lasciato spazio all’emergere dell’atonalità, come in Schönberg, all’appropriazione di sistemi musicali orientali, come in Debussy, all’uso del canto popolare, come in Bartók. Lui, invece, furibondo antiwagneriano e dispregiatore di Puccini che considerava niente più di un abile “businessman” del melodramma, a tale crisi ha risposto voltandosi indietro e teorizzando l’idea di una ‘nuova classicità’. Del resto Busoni aveva una prospettiva ampia, inusuale per l’epoca, sulla musica del passato. E non solo su Bach, perno della sua creatività. Allo stesso momento, comunque, era proiettato in maniera profetica verso il futuro: basti vedere come nel suo “Abbozzo di una nuova estetica della musica”, del 1907, parlasse di microtoni e quanta curiosità mostrasse per un antenato del modulatore ad anello, preconizzando dunque la musica elettronica». Perché le sue opere non fanno presa sul pubblico è presto detto. «Sono pagine dotte, imbastite con troppo intellettualismo da un uomo di straordinaria cultura e incardinate su un pensiero contrappuntistico complesso di stampo bachiano. Difettano della capacità di comunicare. Come il “Doktor Faust”, l’opera incompiuta di cui lui stesso ha redatto il libretto mettendoci dentro Goethe, la mitologia, Marlowe, il teatro di marionette: tante, troppe suggestioni culturali che disorientano lo spettatore». Busoni è stato un musicista cosmopolita, poliglotta, di mentalità tedesca più che italiana, segnato dall’essere cresciuto a Trieste, patria della madre, dall’avere studiato a Graz, dal trovare in Berlino la città d’elezione; eppure durante la Grande Guerra, per non doversi schierare né con l’Italia (dove allora dirigeva il Conservatorio di Bologna) né con la Germania e l’Austria, decise di autoesiliarsi a Zurigo. «Comunque fu sempre molto orgoglioso di essere toscano, anche se il suo rapporto con Empoli è limitato quasi soltanto alla nascita. Fu il padre, empolese, eccellente clarinettista, che volle in tutti modi farlo venire alla luce nella sua terra, perciò, quando la moglie fu sul punto di partorire, la costrinse a mettersi in viaggio da Trieste alla Toscana. Da concertista, Ferruccio suonò spesso a Firenze, e negli anni Dieci l’amico Felice Boghen, insegnante di armonia all’Istituto musicale (l’odierno Conservatorio), tentò di convincerlo, inutilmente, a divenirne direttore». Ma qual è l’immagine di Busoni che emerge dal volume di Dent, che ha costituito il punto di partenza per tutti gli studi successivi sul musicista? «Benché Dent tenda all’agiografia, in virtù della sua ammirazione sconfinata per il carismatico Busoni, talvolta capita che il biografato venga tirato giù dal piedistallo. Accade quando si racconta che, durante una tournée nella provincia inglese insieme al grande violinista Eugène Ysaÿe, il duo arrivò in sala da concerto senza quasi aver mai provato uno dei pezzi forti del recital. La ragione era che Ysaÿe non ne ne aveva voluto mai trovare il tempo, malgrado le numerose sollecitazioni di Busoni, puntiglioso e perfezionista. Al quale però, benché l’autostima non venisse mai meno, quella volta non restò che prendere atto di aver suonato, tutti e due, da cani».
Ferruccio Busoni ha patito in vita e ancora patisce, dopo quasi un secolo dalla morte di non essere valutato, come compositore, quanto meriterebbe. Sulla grandezza del pianista tutti concordano, mentre a proposito delle sue partiture i giudizi divergono drasticamente, e di certo non sono mai entrate in repertorio, tranne qualche trascrizione pianistica dall’adorato Bach (la “Ciaccona”, per esempio). Il 1° aprile Empoli, suo luogo natale, ne celebra online il centocinquantacinquesimo compleanno con diverse iniziative che il Centro studi a lui intitolato propone a grandi e piccini. Occasione per ravvivarne la memoria presso il grande pubblico che fa il paio con l’uscita recente in traduzione italiana, per Polistampa, della prima biografia mai apparsa sul musicista: quella, datata 1933, dell’inglese Edward J. Dent, che per restituire il profilo umano e artistico dell’amico Ferruccio poté contare su ricordi di prima mano e attingere a tanta documentazione privata messagli disposizione dalla vedova Gerda. «Busoni si sentiva un inattuale, sebbene fosse consapevole di costituire un’eccellenza compositiva della sua epoca. Sapeva di aver trovato una strada originalissima, anche se non compresa dai colleghi e dal pubblico. Né, d’altro canto, il venire annoverato tra i più grandi pianisti d’ogni tempo, accanto a Liszt, gli interessava troppo», spiega il curatore del volume Marco Vincenzi, pianista, docente al Conservatorio di Genova e già direttore del Centro studi empolese. Forse, per essere più apprezzato come autore, avrebbe dovuto seguire il consiglio di George Bernard Shaw, che gli suggerì di scrivere sotto pseudonimo, poiché la gente non ammette che una persona sia in grado di far bene più di una cosa, e se uno è già un gran virtuoso del piano si ritiene impossibile che possa pure eccellere nella composizione. «Oggi Busoni continua a restare un inattuale», aggiunge Vincenzi. «Il fatto è che ha abitato un’età di crisi del linguaggio musicale, quando lo sgretolamento della tonalità ha lasciato spazio all’emergere dell’atonalità, come in Schönberg, all’appropriazione di sistemi musicali orientali, come in Debussy, all’uso del canto popolare, come in Bartók. Lui, invece, furibondo antiwagneriano e dispregiatore di Puccini che considerava niente più di un abile “businessman” del melodramma, a tale crisi ha risposto voltandosi indietro e teorizzando l’idea di una ‘nuova classicità’. Del resto Busoni aveva una prospettiva ampia, inusuale per l’epoca, sulla musica del passato. E non solo su Bach, perno della sua creatività. Allo stesso momento, comunque, era proiettato in maniera profetica verso il futuro: basti vedere come nel suo “Abbozzo di una nuova estetica della musica”, del 1907, parlasse di microtoni e quanta curiosità mostrasse per un antenato del modulatore ad anello, preconizzando dunque la musica elettronica». Perché le sue opere non fanno presa sul pubblico è presto detto. «Sono pagine dotte, imbastite con troppo intellettualismo da un uomo di straordinaria cultura e incardinate su un pensiero contrappuntistico complesso di stampo bachiano. Difettano della capacità di comunicare. Come il “Doktor Faust”, l’opera incompiuta di cui lui stesso ha redatto il libretto mettendoci dentro Goethe, la mitologia, Marlowe, il teatro di marionette: tante, troppe suggestioni culturali che disorientano lo spettatore». Busoni è stato un musicista cosmopolita, poliglotta, di mentalità tedesca più che italiana, segnato dall’essere cresciuto a Trieste, patria della madre, dall’avere studiato a Graz, dal trovare in Berlino la città d’elezione; eppure durante la Grande Guerra, per non doversi schierare né con l’Italia (dove allora dirigeva il Conservatorio di Bologna) né con la Germania e l’Austria, decise di autoesiliarsi a Zurigo. «Comunque fu sempre molto orgoglioso di essere toscano, anche se il suo rapporto con Empoli è limitato quasi soltanto alla nascita. Fu il padre, empolese, eccellente clarinettista, che volle in tutti modi farlo venire alla luce nella sua terra, perciò, quando la moglie fu sul punto di partorire, la costrinse a mettersi in viaggio da Trieste alla Toscana. Da concertista, Ferruccio suonò spesso a Firenze, e negli anni Dieci l’amico Felice Boghen, insegnante di armonia all’Istituto musicale (l’odierno Conservatorio), tentò di convincerlo, inutilmente, a divenirne direttore». Ma qual è l’immagine di Busoni che emerge dal volume di Dent, che ha costituito il punto di partenza per tutti gli studi successivi sul musicista? «Benché Dent tenda all’agiografia, in virtù della sua ammirazione sconfinata per il carismatico Busoni, talvolta capita che il biografato venga tirato giù dal piedistallo. Accade quando si racconta che, durante una tournée nella provincia inglese insieme al grande violinista Eugène Ysaÿe, il duo arrivò in sala da concerto senza quasi aver mai provato uno dei pezzi forti del recital. La ragione era che Ysaÿe non ne ne aveva voluto mai trovare il tempo, malgrado le numerose sollecitazioni di Busoni, puntiglioso e perfezionista. Al quale però, benché l’autostima non venisse mai meno, quella volta non restò che prendere atto di aver suonato, tutti e due, da cani».
Data recensione: 26/03/2021
Testata Giornalistica: La Repubblica
Autore: Gregorio Moppi