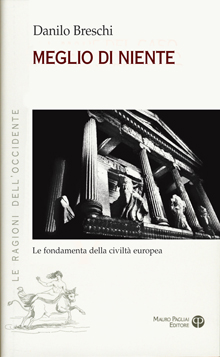Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Uno spettro si aggira per l’Europa: è lo spettro del nichilismo, lo spettro di una società vuota ed apatica
Uno spettro si aggira per l’Europa: è lo spettro
del nichilismo, lo spettro di una società vuota ed apatica che ha smarrito le
radici della propria civiltà e, quindi, della propria identità. È questa la
diagnosi, lucida e perspicace, che emerge dalla lettura del recente libro dello
studioso di formazione liberale Danilo Breschi, e che spinge il lettore non
soltanto a riflettere sulle patologie di questo organismo malmesso che chiamiamo
“Europa”, ma soprattutto sulle possibili cure che si possono somministrare.
L’arduo compito che si è assunto Breschi non si esaurisce infatti nella volontà
di evidenziare la crisi morale della civiltà europea, che è un leitmotiv di
spengleriana memoria, quanto invece di «comprendere la realtà, anche nella sua
crudezza, per meglio combatterla» (p. 7). Soltanto dopo aver acquisito la piena
consapevolezza del nihil in cui il
mondo occidentale pare sia sprofondato è possibile riscoprire il valore
immanente della nostra civiltà. Ma cos’è una civiltà?
Essa, ci dice Breschi, poggia su quattro pilastri fondamentali: la storia, la politica, la religione e l’educazione. La storia è il primo punctum dolens della nostra nazione. Incalzato dalle stimolanti domande di Alain Elkann, alla fine degli anni Novanta, Montanelli profetizzava di non vedere alcun futuro per l’Italia, poiché «un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani». Da allora gli eventi che si sono susseguiti sembrano aver confermato le apocalittiche previsioni di Montanelli, e Breschi non manca di elencare con particolare dovizia le tare che il belpaese si trascina da secoli. Ma, lungi dal voler drammatizzare la situazione, ne trae motivo per sostenere la necessità di «uscire dalla nostra storia nazionale unitaria, che ci ha fatto così come siamo oggi e come resteremo a causa della fortissima vischiosità insita in tradizioni diventate istituzioni» (p. 29).
Breschi sa che uscirne non è facile, dato «il sistema familistico-clientelare e l’attitudine anarco-individualistica» (p. 34) così radicati nell’animo e nel temperamento degli italiani, ma è proprio questa la fase storica che necessita l’innesco di un nuovo processo risorgimentale. E se la politica, sino ad ora, è stata il terreno dello scontro prevaricante di fazioni tra loro contrapposte, scontro talora sfociato in vere e proprie guerre civili, occorre allora «un diverso modo di pensare e praticare la politica, dimensione dell’esistenza umana di cui si dovrebbe riuscire a dimostrare la natura non solo aggressiva e conflittuale» (p. 39). Alla luce di ciò, Breschi auspica una profonda sintesi di idee sia di sinistra che di destra «capace di criticare le élites che hanno tradito la fiducia del popolo ridotto a periodico elettore non partecipante e totalmente ininfluente» (p. 65). Si tratta, questa, di una proposta che vuole al contempo essere una precisa contestazione al populismo che pervade le cronache politiche d’Europa, e che Breschi – a ragione – individua nella destra travestita da populista, ammantata di retorica anti-élitista, ma che finisce poi col sostenere gli interessi finanziari, industriali e oligarchici contro cui si era scagliata in campagna elettorale (Trump docet).
Una controllata dose di populismo, in ogni caso, se iniettata in un corpo dotato di una buona costituzione, può rivelarsi un utile antidoto per “rigenerare” il sistema liberal-democratico. Se iniettata in corpi dalla costituzione debole, come in genere sono – o sono stati – i paesi latini, si rischia una patologia grave (totalitarismo). Tuttavia, ad onor del vero, sarebbe scorretto parlare di populismo, estrema destra, fascismo e neofascismo come fossero termini tra loro intercambiabili, o posti in stretta correlazione l’uno con l’altro. Marco Tarchi, nel suo Italia populista, ha messo bene in guardia contro le false equivalenze ed i facili accostamenti. Più che forze eversive rispetto al sistema, i populismi si configurano essere, accostandoci hegelianamente ad una prospettiva cara a Fukuyama, momenti conflittuali interni alla dialettica del sistema dominante. Ed il populismo, sintetizza ineccepibilmente Breschi, è «ideologia politica che si affida a messaggi che solleticano e sollecitano la pancia ignorando la testa» (p. 80). Più che voler costituire delle reali o radicali alternative propositive, i populisti fanno leva sulle paure e sugli istinti atavici delle masse le quali, si sa, sono facilmente manipolabili da chi promette loro panem et circenses.
La crisi politica che attanaglia l’Europa è l’occasione propizia, secondo Breschi, per riaffermare il primato ideale della democrazia liberale di massa, che è stata una delle più grandiose e faticose conquiste del pensiero moderno. La democrazia liberale è qui intesa come la costruzione di uno spazio giuridico all’interno del quale i cittadini – liberi e uguali – possono decidere «chi deciderà le questioni riguardanti il vivere associato» (p. 99). Il liberalismo democratico di Breschi finisce in questo modo per apparire assai distante dal vecchio liberalismo antidemocratico, come quello sostenuto da Panfilo Gentile, proteso a denunciare il principio della «sovranità popolare», considerando le moltitudini incapaci e incompetenti a dirigere gli affari dello Stato (cfr. Democrazie mafiose, 2005).
Breschi non manca, inoltre, di denunciare le minacce e i pericoli insiti nei sistemi democratici: alla crescente e incontrollata egemonia del neoliberismo, vi contrappone la necessità di ricondurre i mercati sotto l’egida del controllo pubblico; all’artificioso e forzato binomio pluralismo/multiculturalismo, ricorda che il vero pluralismo deve riconoscere e valorizzare le differenze, e che le integrazioni si fondano sulla «ricerca di un equilibrio vitale e virtuoso tra unità e pluralità» (p. 95); ed infine, al pericolo della formazione dell’ideologia intollerante del “politicamente corretto” (il cosiddetto pensiero unico dominante, denunciato nel 1995 da Ignacio Ramonet), sostiene l’inesistenza di verità «universalmente intellegibili» ed eterogenee come i «valori» (p. 101). I dogmi e i luoghi comuni, spacciati come verità assolute, imbrigliano il pensiero in un conformismo strisciante, costituendo un ostacolo alla libertà di pensiero e alla ricerca critica della verità, che è uno dei lasciti della filosofia greca. Ed è contro le “verità consolidate” che Michel Foucault ha invitato alla “disobbedienza ragionata” e alla dissidenza critica. Terzo, ma non meno importante, pilastro di una civiltà è la religione. Condannata dal marxismo quale “oppio dei popoli”, considerata in fase di estinzione a causa della poderosa e inarrestabile avanzata della secolarizzazione, la religione continua a proliferare e a porsi quale punto di riferimento morale per milioni di individui. Volenti o nolenti la religione è tutt’ora una “forza morale” con cui l’Europa liberale deve confrontarsi.
Per secoli la religione è stata il bersaglio privilegiato di ateisti e laicisti, razionalisti e liberali, unitamente concordi nella volontà di relegarla nello ristretto ambito della sfera personale e privata dei singoli individui, tenuta a debita distanza perché potenzialmente in grado di influenzare le istituzioni con la sua forza di persuasione. In pochi coloro che, come Breschi, sono disposti a riconoscere le solide radici cristiane d’Europa, nonché la portata rivoluzionaria del messaggio biblico: «l’insegnamento cristiano ha costituito una svolta epocale, irradiando nel mondo il principio di uguaglianza e un durissimo attacco all’ego coltivato dai miti e dalle filosofie precristiane» (p. 141). La fisionomia della civiltà europea è il risultato di un ben riuscito sincretismo: quello tra paganità e cristianesimo, tra ragione e fede, tra Socrate e Gesù. Fu il pontefice Benedetto XVI, ricorda Breschi, ad aprire il dialogo tra il cattolicesimo e il liberalismo laico e agnostico, un confronto che avrebbe potuto portare ad un «fecondo scambio di idee e valori tra laici liberali e cattolici, soprattutto in un contesto europeo» (p. 148). Un’opportunità, questa, morta ancor prima di nascere.
L’importanza dell’educazione nella vita di un popolo, che è il quarto pilastro su cui si regge l’impalcatura di una civiltà, era stata a suo tempo ben compresa da Giuseppe Mazzini, anch’egli liberale, ma di un liberalismo con forti connotati mistici e palingenetici. Secondo Mazzini: «L’educazione è il pane dell’anima. Come la vita fisica, organica, non può crescere e svolgersi senza alimenti, così la vita morale, intellettuale, ha bisogno per ampliarsi e manifestarsi, delle influenze esterne e d’assimilarsi parte almeno delle idee, degli effetti, delle altrui tendenze». Il nichilismo occidentale ha potuto prosperare grazie ad una cattiva educazione o, meglio ancora, ad una assenza di educazione, che ha lasciato il campo a strumenti del tutto irresponsabili come la televisione e la rete. La televisione, quella “cattiva maestra” denunciata da Popper, «è stata e resta la prima sorgente di devastazione mentale e culturale della nostra nazione» (p. 165), a cui fa seguito la rete, che è il «ricettacolo della più stantia e vieta poltiglia complottista e dietrologista, qualunquista e moralista, che mai si sia vista nella storia occidentale dell’intolleranza e della violenza, oggi visiva e verbale, domani fisica» (p. 168). Questi pervasivi strumenti di massificazione sociale hanno diseducato i giovani dal senso civico di responsabilità, favorito la diffusione capillare della pornografia – che è la degradazione più volgare della donna a oggetto del piacere maschile –, e annebbiato le menti impedendo lo sviluppo di una sana coscienza critica.
L’antidoto, ora e sempre, è costituito, nelle scuole e nelle università, dall’apporto formativo di quelle “discipline umanistiche” che sono il sostrato imprescindibile della nostra civiltà. Accostarsi ai classici è un atto di conservazione rivoluzionaria «in un mondo che muta troppo rapidamente, sradica e disorienta, facendoci smarrire la nostra humanitas» (p. 163). Recuperare quelli che sono i pilastri della civiltà italiana, europea e occidentale significa, oggi, preferire “qualcosa” al nulla più assoluto. Meglio di niente.
Essa, ci dice Breschi, poggia su quattro pilastri fondamentali: la storia, la politica, la religione e l’educazione. La storia è il primo punctum dolens della nostra nazione. Incalzato dalle stimolanti domande di Alain Elkann, alla fine degli anni Novanta, Montanelli profetizzava di non vedere alcun futuro per l’Italia, poiché «un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani». Da allora gli eventi che si sono susseguiti sembrano aver confermato le apocalittiche previsioni di Montanelli, e Breschi non manca di elencare con particolare dovizia le tare che il belpaese si trascina da secoli. Ma, lungi dal voler drammatizzare la situazione, ne trae motivo per sostenere la necessità di «uscire dalla nostra storia nazionale unitaria, che ci ha fatto così come siamo oggi e come resteremo a causa della fortissima vischiosità insita in tradizioni diventate istituzioni» (p. 29).
Breschi sa che uscirne non è facile, dato «il sistema familistico-clientelare e l’attitudine anarco-individualistica» (p. 34) così radicati nell’animo e nel temperamento degli italiani, ma è proprio questa la fase storica che necessita l’innesco di un nuovo processo risorgimentale. E se la politica, sino ad ora, è stata il terreno dello scontro prevaricante di fazioni tra loro contrapposte, scontro talora sfociato in vere e proprie guerre civili, occorre allora «un diverso modo di pensare e praticare la politica, dimensione dell’esistenza umana di cui si dovrebbe riuscire a dimostrare la natura non solo aggressiva e conflittuale» (p. 39). Alla luce di ciò, Breschi auspica una profonda sintesi di idee sia di sinistra che di destra «capace di criticare le élites che hanno tradito la fiducia del popolo ridotto a periodico elettore non partecipante e totalmente ininfluente» (p. 65). Si tratta, questa, di una proposta che vuole al contempo essere una precisa contestazione al populismo che pervade le cronache politiche d’Europa, e che Breschi – a ragione – individua nella destra travestita da populista, ammantata di retorica anti-élitista, ma che finisce poi col sostenere gli interessi finanziari, industriali e oligarchici contro cui si era scagliata in campagna elettorale (Trump docet).
Una controllata dose di populismo, in ogni caso, se iniettata in un corpo dotato di una buona costituzione, può rivelarsi un utile antidoto per “rigenerare” il sistema liberal-democratico. Se iniettata in corpi dalla costituzione debole, come in genere sono – o sono stati – i paesi latini, si rischia una patologia grave (totalitarismo). Tuttavia, ad onor del vero, sarebbe scorretto parlare di populismo, estrema destra, fascismo e neofascismo come fossero termini tra loro intercambiabili, o posti in stretta correlazione l’uno con l’altro. Marco Tarchi, nel suo Italia populista, ha messo bene in guardia contro le false equivalenze ed i facili accostamenti. Più che forze eversive rispetto al sistema, i populismi si configurano essere, accostandoci hegelianamente ad una prospettiva cara a Fukuyama, momenti conflittuali interni alla dialettica del sistema dominante. Ed il populismo, sintetizza ineccepibilmente Breschi, è «ideologia politica che si affida a messaggi che solleticano e sollecitano la pancia ignorando la testa» (p. 80). Più che voler costituire delle reali o radicali alternative propositive, i populisti fanno leva sulle paure e sugli istinti atavici delle masse le quali, si sa, sono facilmente manipolabili da chi promette loro panem et circenses.
La crisi politica che attanaglia l’Europa è l’occasione propizia, secondo Breschi, per riaffermare il primato ideale della democrazia liberale di massa, che è stata una delle più grandiose e faticose conquiste del pensiero moderno. La democrazia liberale è qui intesa come la costruzione di uno spazio giuridico all’interno del quale i cittadini – liberi e uguali – possono decidere «chi deciderà le questioni riguardanti il vivere associato» (p. 99). Il liberalismo democratico di Breschi finisce in questo modo per apparire assai distante dal vecchio liberalismo antidemocratico, come quello sostenuto da Panfilo Gentile, proteso a denunciare il principio della «sovranità popolare», considerando le moltitudini incapaci e incompetenti a dirigere gli affari dello Stato (cfr. Democrazie mafiose, 2005).
Breschi non manca, inoltre, di denunciare le minacce e i pericoli insiti nei sistemi democratici: alla crescente e incontrollata egemonia del neoliberismo, vi contrappone la necessità di ricondurre i mercati sotto l’egida del controllo pubblico; all’artificioso e forzato binomio pluralismo/multiculturalismo, ricorda che il vero pluralismo deve riconoscere e valorizzare le differenze, e che le integrazioni si fondano sulla «ricerca di un equilibrio vitale e virtuoso tra unità e pluralità» (p. 95); ed infine, al pericolo della formazione dell’ideologia intollerante del “politicamente corretto” (il cosiddetto pensiero unico dominante, denunciato nel 1995 da Ignacio Ramonet), sostiene l’inesistenza di verità «universalmente intellegibili» ed eterogenee come i «valori» (p. 101). I dogmi e i luoghi comuni, spacciati come verità assolute, imbrigliano il pensiero in un conformismo strisciante, costituendo un ostacolo alla libertà di pensiero e alla ricerca critica della verità, che è uno dei lasciti della filosofia greca. Ed è contro le “verità consolidate” che Michel Foucault ha invitato alla “disobbedienza ragionata” e alla dissidenza critica. Terzo, ma non meno importante, pilastro di una civiltà è la religione. Condannata dal marxismo quale “oppio dei popoli”, considerata in fase di estinzione a causa della poderosa e inarrestabile avanzata della secolarizzazione, la religione continua a proliferare e a porsi quale punto di riferimento morale per milioni di individui. Volenti o nolenti la religione è tutt’ora una “forza morale” con cui l’Europa liberale deve confrontarsi.
Per secoli la religione è stata il bersaglio privilegiato di ateisti e laicisti, razionalisti e liberali, unitamente concordi nella volontà di relegarla nello ristretto ambito della sfera personale e privata dei singoli individui, tenuta a debita distanza perché potenzialmente in grado di influenzare le istituzioni con la sua forza di persuasione. In pochi coloro che, come Breschi, sono disposti a riconoscere le solide radici cristiane d’Europa, nonché la portata rivoluzionaria del messaggio biblico: «l’insegnamento cristiano ha costituito una svolta epocale, irradiando nel mondo il principio di uguaglianza e un durissimo attacco all’ego coltivato dai miti e dalle filosofie precristiane» (p. 141). La fisionomia della civiltà europea è il risultato di un ben riuscito sincretismo: quello tra paganità e cristianesimo, tra ragione e fede, tra Socrate e Gesù. Fu il pontefice Benedetto XVI, ricorda Breschi, ad aprire il dialogo tra il cattolicesimo e il liberalismo laico e agnostico, un confronto che avrebbe potuto portare ad un «fecondo scambio di idee e valori tra laici liberali e cattolici, soprattutto in un contesto europeo» (p. 148). Un’opportunità, questa, morta ancor prima di nascere.
L’importanza dell’educazione nella vita di un popolo, che è il quarto pilastro su cui si regge l’impalcatura di una civiltà, era stata a suo tempo ben compresa da Giuseppe Mazzini, anch’egli liberale, ma di un liberalismo con forti connotati mistici e palingenetici. Secondo Mazzini: «L’educazione è il pane dell’anima. Come la vita fisica, organica, non può crescere e svolgersi senza alimenti, così la vita morale, intellettuale, ha bisogno per ampliarsi e manifestarsi, delle influenze esterne e d’assimilarsi parte almeno delle idee, degli effetti, delle altrui tendenze». Il nichilismo occidentale ha potuto prosperare grazie ad una cattiva educazione o, meglio ancora, ad una assenza di educazione, che ha lasciato il campo a strumenti del tutto irresponsabili come la televisione e la rete. La televisione, quella “cattiva maestra” denunciata da Popper, «è stata e resta la prima sorgente di devastazione mentale e culturale della nostra nazione» (p. 165), a cui fa seguito la rete, che è il «ricettacolo della più stantia e vieta poltiglia complottista e dietrologista, qualunquista e moralista, che mai si sia vista nella storia occidentale dell’intolleranza e della violenza, oggi visiva e verbale, domani fisica» (p. 168). Questi pervasivi strumenti di massificazione sociale hanno diseducato i giovani dal senso civico di responsabilità, favorito la diffusione capillare della pornografia – che è la degradazione più volgare della donna a oggetto del piacere maschile –, e annebbiato le menti impedendo lo sviluppo di una sana coscienza critica.
L’antidoto, ora e sempre, è costituito, nelle scuole e nelle università, dall’apporto formativo di quelle “discipline umanistiche” che sono il sostrato imprescindibile della nostra civiltà. Accostarsi ai classici è un atto di conservazione rivoluzionaria «in un mondo che muta troppo rapidamente, sradica e disorienta, facendoci smarrire la nostra humanitas» (p. 163). Recuperare quelli che sono i pilastri della civiltà italiana, europea e occidentale significa, oggi, preferire “qualcosa” al nulla più assoluto. Meglio di niente.
Data recensione: 01/05/2018
Testata Giornalistica: Europea
Autore: Antonio Messina